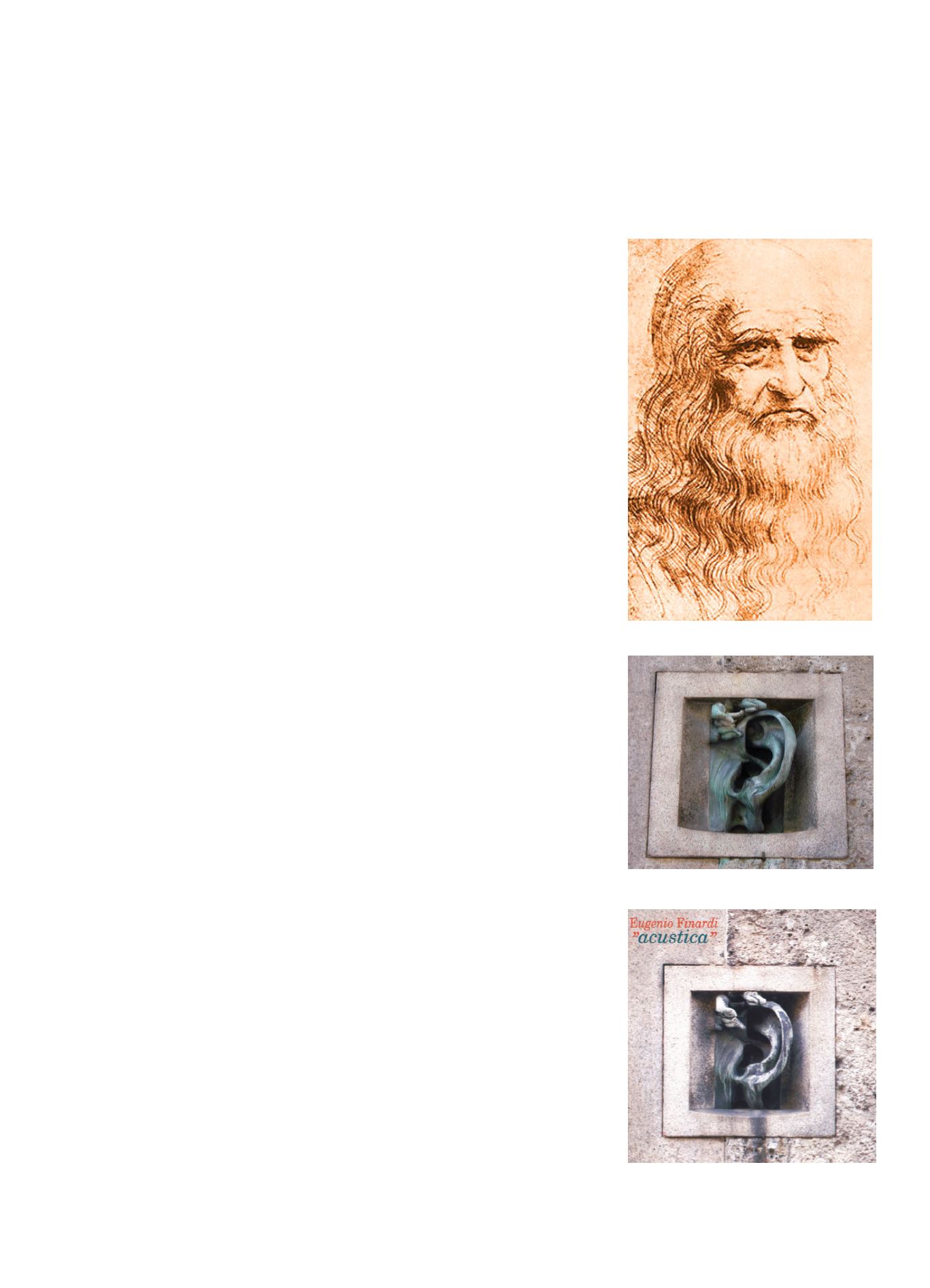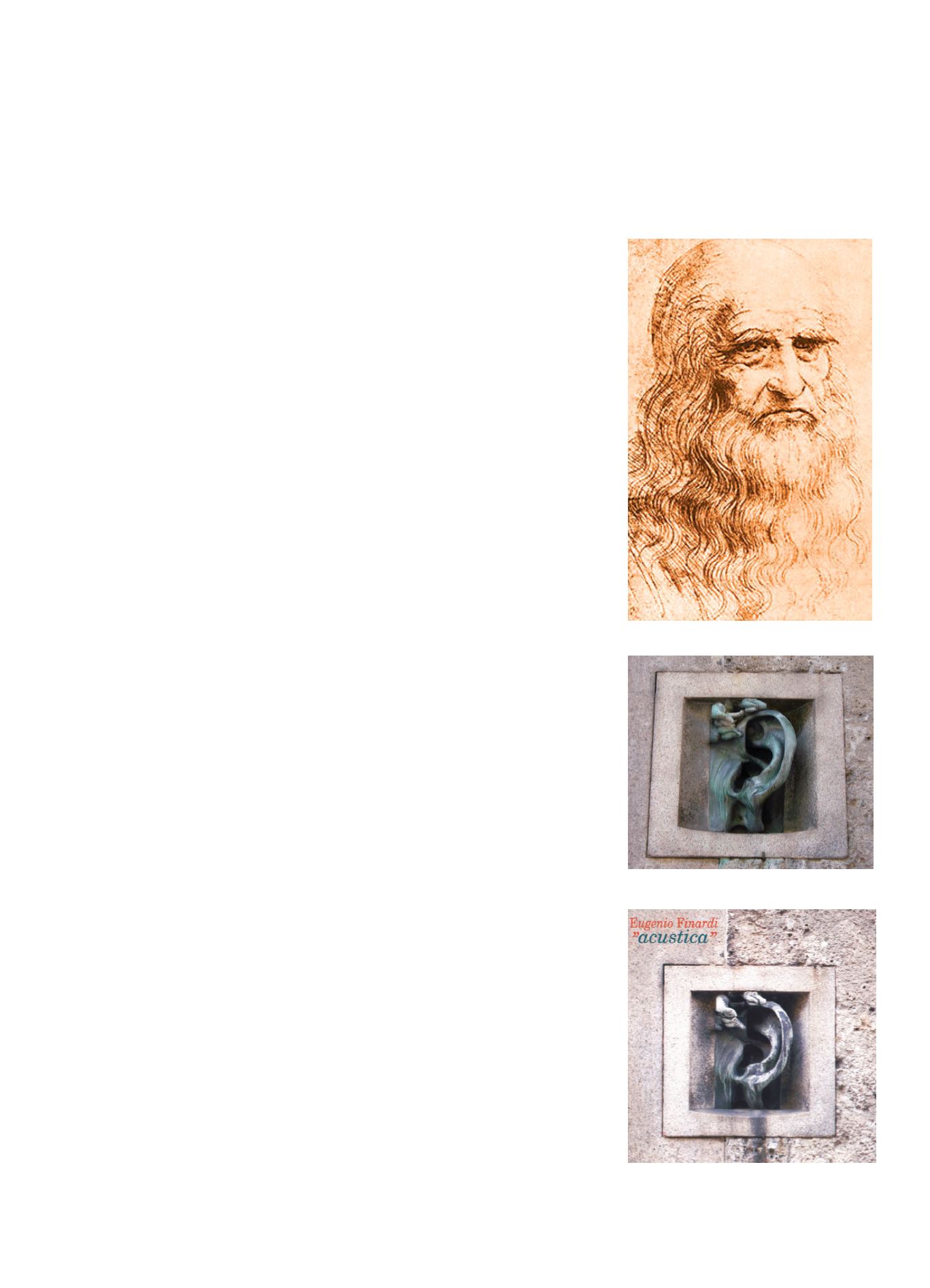
a
ttualità
e
lettrotecnica - dicembre
2015
- numero
10
14
di Dino Pellizzaro
care il messaggio o un’immagine anche remo-
tamente, via cellulare. Come si vede la tecno-
logia può arrivare prima della lingua. Interes-
sante la citazione, sempre presente nel forum
de La Crusca: “Il campanello, quindi, serve
per SUONARE. Il citofono, invece, serve solo
per COMUNICARE. Diverso il caso – questo
posso concederglielo – dei citofoni che metto-
no in comunicazione tra loro diversi interni di
uno stesso stabile o – ad esempio – diversi
piani di una stessa scuola o di uno stesso edi-
ficio. Quelli sì, possono suonare. Ma quando
si va in una casa altrui non si suona mai il cito-
fono, ma – sia fuori che dentro – sempre il
campanello. E il verbo ‘citofonare’, di conse-
guenza, è da riferirsi, a mio avviso, solo all’at-
to di ‘parlare o comunicare attraverso citofono’
e non all’atto di ‘suonare’.”.
Chi l’ha inventato
Ma chi ha inventato il citofono? Almeno dal
punto di vista dell’idea, Leonardo, ovviamen-
te, visto che ha inventato quasi tutto. In un suo
disegno nel Codice Atlantico, si vede un lungo
tubo di rame che collega due torri in cui sono
presenti degli antesignani degli altoparlanti.
L’invenzione poteva servire per la difesa delle
fortezze. Una sua ricostruzione è stata pre-
sentata nel 2003 al Museo Ideale di Leonardo
nel paese natale del nostro connazionale, Vin-
ci, nei pressi di Empoli. La distanza tra le due
torri (stazioni comunicanti) poteva essere an-
che di qualche kilometro. E l’idea stessa anti-
cipa in qualche modo le invenzioni di Bell di
Meucci. Leonardo a questo proposito scrive:
‘’Parleransi li omini di remotissimi paesi l’uno
all’altro, e risponderansi’’, e anche “...in cento
miglia…cento case, nelle quali stia cento
guardie, che faranno per sotterranei condotti
sentire una novella in un quarto d’ora”. Inrte-
ressante anche il primo citofono “orecchio-
morfo”. Lo trovate in centro a Milano, in via
Serbelloni al 10, in un edificio in stile liberty
che popolarmente dai milanesi è stato nomi-
nato la “Cà de l’oreggia”, la casa dell’orec-
chio. Qui, un celebre scultore, Adolfo Wildt, ha
realizzato nel 1930 un orecchio in bronzo che,
allora, serviva da citofono. Ora non funziona
più ma il suo fascino rimane, tanto che è stato
riprodotto nella copertina di un album di Euge-
Q
uesta volta trattiamo l’argomento con
leggerezza, lasciando ad altri spazi
l’approfondimento sulle caratteristi-
che tecniche-tecnologiche di questo ogget-
to diffusissimo e che non manca mai di stu-
pire. Partiamo dalla definizione di citofono
presente nella Treccani:
citòfono
s. m. [comp. del lat. citus «rapi-
do» e -fono di telefono]. – Impianto telefoni-
co interno che collega la portineria o l’ester-
no di uno stabile con i singoli appartamenti,
o anche parti di un’abitazione lontane tra lo-
ro: può essere a microtelefono, ad altopar-
lante (che funziona anche da microfono, co-
me negli impianti interfonici), o di tipo misto
(per es., a microtelefono a un estremo e ad
altoparlante all’altro estremo); le operazioni
di chiamata e di commutazione sono effet-
tuate mediante pulsanti.
Certamente riduttivo, non vi sembra? Le attua-
li tecnologie offrono, come si può vedere dai
prodotti attualmente in commercio, ben altro.
Limitiamoci qui ad offrire alcuni spunti partico-
lari, lasciando al resto dello speciale in compi-
to di entrare nel merito delle tecnologie.
Sulla definizione
È interessante riassumere qui alcuni particola-
ri interventi sul citofono avvenuto sul forum
dell’Accademia della Crusca, la prestigiosa
istituzione italiana che raccoglie studiosi ed
esperti di linguistica e filologia della lingua ita-
liana. Gli Autori si soffermano sull’improprio
modo di dire suonare al (o il) citofono come
“mentre ero in casa ho sentito suonare il cito-
fono”. In realtà “Suonare il campanello è
un’azione possibile, suonare il citofono è
un’azione impossibile”. Una definizione pre-
sente nel forum dice: “A mio avviso, invece, è
da chiamarsi citofono: 1) l’apparecchio che
sta o vicino al cancello o vicino al portone (in
ogni caso sempre fuori dal fabbricato) e che
permette alla persona che si trova “fuori” di
comunicare con la persona che si trova “den-
tro”; 2) il ricevitore collocato all’interno del-
l’abitazione, che è collegato con il citofono
esterno e che permette alla persona che si tro-
va “dentro” di comunicare con quella che si
trova “fuori””. Ma allo stato delle tecnologie at-
tuali ci sembra riduttiva. Oggi si può comuni-
Il citofono è considerato una “banale”
applicazione ormai universalmente
installata. Vero, ma non è un
oggetto banale e molte cose
sui suoi usi o la sua storia
sono poco note
due o tre cose
che
non si sanno di lui
Fig. 1 – Ritratto di Leonardo
Fig. 2 – L’orecchio di Wildt
Fig. 3 – Copertina dell’album di Finardi